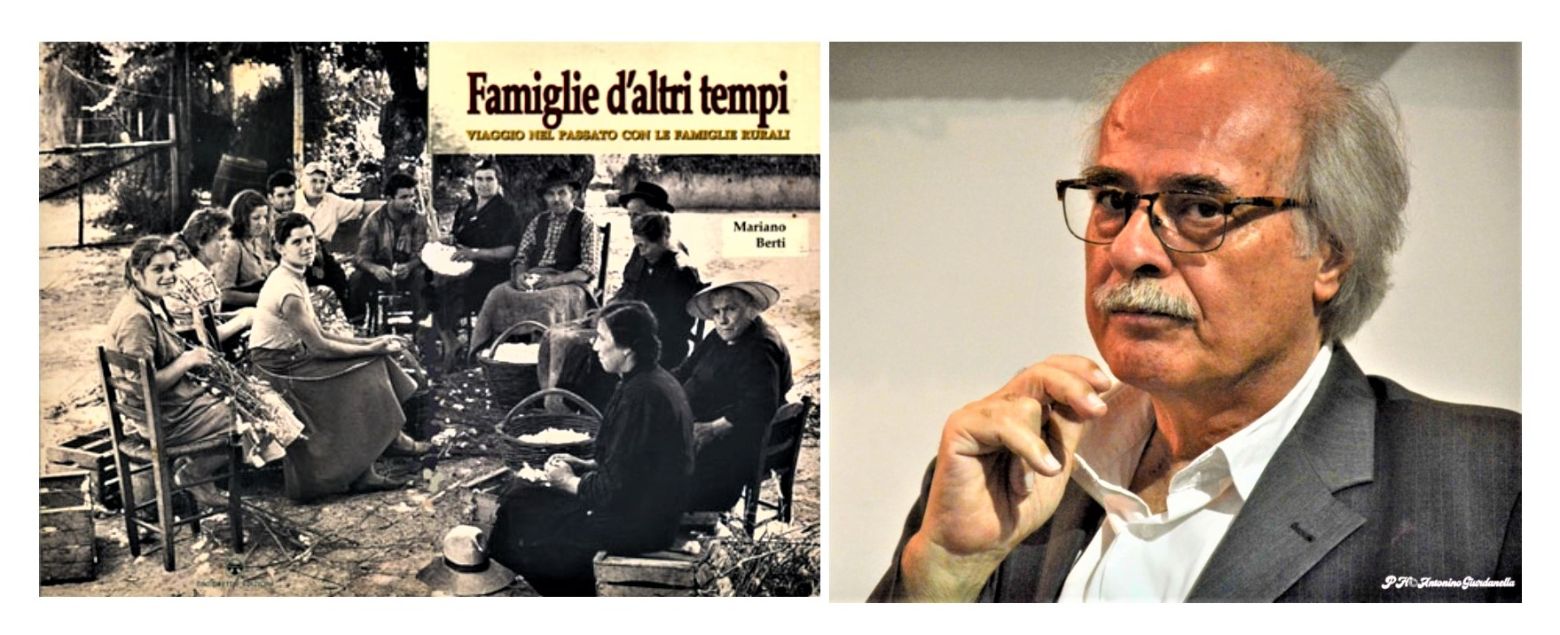
I rapporti tra i membri della famiglia patriarcale siciliana si muovevano all’interno di una concezione gerarchica. Il padre con il suo rigoroso autoritarismo, costituiva il vertice cui facevano riferimento tutti gli altri membri della famiglia, i quali si concepivano, pensavano ed agivano non come singoli e con una propria individualità, ma come membri di un gruppo che contribuivano come potevano al reddito familiare, e che sottostavano al ruolo unificante del padre e alla sua autorità assoluta.
Questa struttura gerarchica faceva sì che tra i ruoli familiari non ci fosse alcuna confusione e ingenerava una sorta di rapporti del tipo padrone-servo, tant’è che quando il figlio si trovava al cospetto del padre doveva tenersi ad una rispettosa distanza ed in forma composta ed attenta, doveva usare la terza persona e parlare evitando eccessiva familiarità(1) ed espressioni sconvenienti; doveva ancora evitare di fare osservazioni, domande o di dare consigli non richiesti.
I genitori concepivano la propria casa come una palestra in cui i figli dovevano ricevere un’educazione severa, al punto che era sufficiente uno sguardo negli occhi per sapere cosa il padre volesse esprimere. Nell’età più tenera non mancavano le effusioni sentimentali e i compiacimenti dei genitori per la crescita dei figli(2); una volta poi raggiunta l’età più adulta, la madre si preoccupava di avviare la figlia ai lavori domestici, mentre il padre dirigeva il maschio verso il lavoro dei campi, inculcando l’idea che il sole, la pioggia, il vento e tutte le mutazioni climatiche contribuivano a dare una crescita sana e robusta(3). I figli erano numerosi e solo pochi venivano avviati agli studi; l’obiettivo primario dell’educazione non era tuttavia il corpo, l’avere e la ricchezza, ma l’anima del figlio, affinché egli potesse crescere nella religione dei genitori(4), intraprendere un progresso morale e diventare così onesto, buono e virtuoso. L’educazione, inoltre, si concretizzava in un controllo e in un intervento deciso e sistematico nella vita del figlio, con una metodologia improntata a caratteri di tempestività e severità.
L’intervento educativo dei genitori siciliani non si riduceva alla dimensione materiale, anzi, il loro amore era “scevro delle delicatezze che avvizziscono i corpi e viziano gli animi”(5).
In sostanza il problema dei coniugi non era solo quello di essere madre e padre che non facevano morire di fame, che davano il necessario, ma quello di essere educatori in grado di far crescere non nel vizio ma nella virtù(6).
Ma quali erano i principi fondamentali che guidavano e motivavano il sistema educativo della famiglia siciliana? Possiamo affermare che due erano sostanzialmente i principi di orientamento:
a) Il principio della continuità: l’educazione mirava a salvaguardare la trasmissione di valori, norme, comportamenti propri del vissuto familiare patriarcale. I figli, sin da piccoli, si identificavano con la collettività familiare e ne assimilavano i pensieri e le modalità comportamentali; si integravano, inoltre, nell’ambiente rurale in cui vivevano e nel quale cercavano la loro realizzazione;
b) il principio dell’autonomia educativa: la struttura della famiglia patriarcale siciliana aveva una sua sufficienza non solo nel campo economico, ma anche in quello sociale ed educativo. La famiglia, infatti, riusciva a prevalere persino sulla struttura statale e ad influenzare la formazione dei suoi membri; l’apprendimento, l’addestramento professionale, il lavoro, erano tutte realtà interne ad essa. I modelli di riferimento si trovavano in famiglia, sicché non veniva delegato all’esterno l’assolvimento delle funzioni educative. Il sistema educativo aveva poi le sue tappe metodologiche, che erano improntate alla rigidità, severità, al dare punizioni per una giusta correzione dei figli.
La prassi educativa si snodava tenendo conto I seguenti aspetti:
– la formazione del carattere sin dalla prima infanzia: “l’arvulu mentri è picciulu s’addrizza” (l’albero si raddrizza mentre è piccolo). Il proverbio evidenziava la necessità di plasmare la vita dei figli intervenendo sin dalla tenera età, per far sì che crescessero sani moralmente;
– l’insegnamento e l’esempio: “Porci e figghioli comu l’inzigni li trovi” (porci e figlioli come insegni loro, così li trovi);
– la cura e il controllo: “lu furmaggiu ca’ nun si mania spissu fa li vermi” (il formaggio che non si “maneggia” spesso fa i vermi). Tale detto aveva come termini di paragone il formaggio e i figli. Come per ben conservare il formaggio bisognava spesso maneggiarlo, rivoltarlo, ungerlo col suo stesso grasso così altrettante cure bisognava usare con i figli, i quali venivano curati, controllati e anche puniti, se occorreva, affinché non facessero i “vermi” ovvero non prendessero una cattiva strada;
– la punizione: “chianciri fa bene a li figghioli” (piangere fa bene ai figli).
Il primato della dimensione parentale: il comparatico
Una caratteristica tipica della famiglia siciliana era quell’intreccio di rapporti intrafamiliari che si stabiliva in modo assolutizzante e che sfociava quasi sempre nel cosiddetto “San Giuvanni”, ossia il “comparatico” o “padrinato”. Si trattava di un legame vero e proprio che assumeva toni di sacralità, tant’è che quando c’era di mezzo “lu San Giuvanni” si vivevano atteggiamenti ben precisi: deferenza, comunicazione reciproca di consigli e idee, di gioie e dolori e perfino di problemi intimi. Insomma, il Comparatico nella cultura siciliana era l’unione profonda di due nuclei familiari, e tale unione generalmente veniva sigillata dopo la celebrazione del battesimo.
La scelta del padrino esigeva il rispetto di alcune regole comportamentali dal significato ambivalente; in pratica, si seguiva una prassi che teneva conto dei seguenti criteri:
a) gli interessi del gruppo familiare: il padrino veniva scelto con oculatezza in quanto non doveva ostacolare il livello sociale raggiunto dalla famiglia, ma, anzi, doveva amalgamarsi agli interessi globali del clan familiare visto che ne doveva condividere la vita e il destino;
b) l’appartenenza ad un “buon partito”: poiché il comparatico determinava la nascita di relazioni interfamiliari, il padrino in genere era di buona famiglia in quanto nella cultura siciliana i rapporti interfamiliari creati con il diventare padrini di battesimo, cresima e matrimonio costituivano un metro di misurazione del gradino raggiunto nella scala sociale. A riguardo è abbastanza significativo un proverbio che sottolinea l’importanza di avere quanto più possibile compari in seno alla propria famiglia:
“Tanti San Giuvanni si guadagnanu,
tanti scaluna di paradisu s’assummanu”(7)
Tanti comparati si riescono a fare,
tanti scalini del paradiso si assommano”.
L’esperienza del comparatico assumeva, una volta celebrato il battesimo e dopo che il padrino entrava a far parte della famiglia, connotazioni relazionali di carattere quasi assoluto:
– il figlioccio portava un rispetto quasi sacro al padrino, rispetto che in concreto si manifestava con l’obbedienza;
– i membri della famiglia del battezzato o cresimato stabilivano con il compare rapporti stretti ed improntati a fiducia e lealtà;
– questo legame reciproco si manifestava sia a livello affettivo che culturale, sociale e religioso.
Alla luce di questa reciprocità che veniva a stabilirsi tra le famiglie, il comparatico non era da prendere per scherzo e, pertanto, occorreva stare vigili per evitare tradimenti ed offese alla santità di esso, come si evince da proverbi siciliani che considerano S. Giovanni Battista “il santo per eccellenza, il cui nome e giorno hanno saputo raccogliere in ogni parte del mondo il più gran numero di usi, credenze e tradizioni, e che il popolo siciliano ha tolto a protettore e vindice del comparatico, parentato unico piuttosto che raro nel suo genere e ne’ particolari che offre. Basti sapere che con S. Giovanni non si scherza: “Di l’autri Santi riditimi, ma nun pigghiari ‘mprisa cu San Giuvanni”, perché egli punisce inesorabilmente coloro che recano offesa alla santità del comparatico: e se non fosse che nei tre giorni che precedono la festa egli s’addormenta, chi sa che cosa avverrebbe: “Si San Giuvanni tri jorna ‘un durmissi, oh quantu e quantu così nni farrissi!” Ma per mala o buona ventura, “Nun sempri è Sangiuvanni””(8).
La legge del comparatico era, dunque, molto severa e non ammetteva che si cadesse in errore circa i rapporti intrafamiliari; alcune leggende attestano che il padrino rischiava addirittura la vita se, anziché rivolgere le attenzioni al figlioccio, le avesse indirizzate verso la “comare”.
Il valore della dimensione interfamiliare si esprimeva nella cultura siciliana non solo attraverso il comparatico, ma anche mediante la relazione parentale. L’amore, infatti, si indirizzava in primo luogo ai parenti e solo successivamente si allargava agli amici e agli altri. Due proverbi, a riguardo, sono estremamente significativi:
“Fa beni prima a li parenti toi,
doppu a cu piaci di l’amici toi”,(9)
Fa’ del bene prima ai parenti tuoi,
dopo a chi vuoi degli amici tuoi.
“Tri suni i così amati:
‘a mamma, i soru e ‘i frati”.(10)
Tre sono le cose amate:
la mamma, le sorelle e i fratelli.
Se il rapporto parentale aveva questo primato, è anche vero che nell’ethos familiare isolano spesso assumeva anche connotazioni negative e aspetti irti di difficoltà e problemi.
E, difatti, era opinione comune che per vivere felici bisognasse stare lontano dai parenti e che con essi bisognasse fare carte scritte per evitare il rischio di trovarsi fregati:
“Si vo campari ‘na vita cuntenti,
stà luntanu d’i tò parenti”(11)
Se vuoi vivere una vita felice,
sta lontano dai tuoi parenti
“Ccu l’amici pattu,
ccu li parenti contrattu” (12)
Con gli amici patto,
ma con i parenti contratto.
Inoltre, la dimensione parentale era attraversata dal pregiudizio che i rapporti con i parenti e gli amici fossero spesso occasione di sospetti, ingiustizie e imbrogli; nonché da una mentalità utilitaristica che invitava a fuggire i parenti:
“’Ntra amici a parenti
nun s’accatta e nun si vinni nenti”(13).
Tra amici e parenti
non si compra e non si vende niente.
“Parenti ca nun ti duna,
amicu ca nun si presta:
fujili comu la pesta”(14).
Parente che non ti dà nulla,
amico che non si presta:
fuggili come la peste.
In conclusione, anche i rapporti extra ed intrafamiliari sono espressione della ambivalenza degli atteggiamenti tipici della famiglia siciliana nei confronti di quel mondo a lei astante e costituito da amici e parenti; atteggiamenti che alternano all’amore amicale e parentale diffidenza, sospetto e distacco fortemente motivati./ Continua
_________________________
(1) “Nella contea di Modica il contadino è in casa l’autocrate; la moglie gli dà del voi, lo serve a tavola prima che esso sieda; i figli devono chiedergli la benedicità (il permesso) ad ogni occasione”. (R. SOLARINO, L’inchiesta agraria nelle due Raguse , s.e. Ragusa 1878, p. 68).
(2) “Il padre va orgoglioso del suo bambino e della sua bambina dagli occhi vivaci, dalle labbra coralline, dalle membra rosee e tonde, che conduce seco sulle braccia nei giorni di festa e di svago” (S. PISANO BAUDO, Sortino e dintorni, Lentini, 1911, pp. 82-83).
(3) Ibid., p. 83.
(4) “I figli sono educati alla religione nella quale nacquero e crebbero i genitori. La madre esercita anche in questo la sua influenza. Le famiglie timorate recitano giornalmente le ordinarie divozioni e pregano il Signore per i genitori, per i fratelli vicini o lontani, che Egli dia Toro la salute e la provvidenza”. (G. PITRE’, La famiglia, la casa, la vita del popolo siciliano, op. cit., p. 36).
(5) S. PISANO BAUDO, op. cit., p. 82-83.
(6) “Biddizza senza virtu / prestu svanisci”, La bellezza senza la virtù / svanisce presto. (R. FRATTALLONE, op. cit., p.217).
(7) R. FRATTALLONE, Proverbi siciliani. Una visione sapienziale della vita, Ed. Oftes, Messina, 1991, p. 83.
(8) G. PITRÈ, Proverbi, motti e scongiuri del popolo siciliano, C. Clausen, Torino, 1910, p. CLXVIL.
(9) R. FRATTALLONE, op. cit., p. 125.
(10) Ibid., p. 126.
(11) Ibid., p. 126.
(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) Ibid., p. 127.
























2 commenti su “La famiglia patriarcale siciliana/4… di Domenico Pisana”
Auspichiamo che il prof.Pisana ci parli anche del matriarcato diffuso nel modicano, in quel di Modica Alta in particolare.
E’ un Documento da custodire. La. Peggiore corsa che e’ in atto e’ il dimenticare. Le..le nostre forti radici, la cultura della nostra contea Babba ma produttrice. Creare un tale périodique..penso sia da Apprezzare