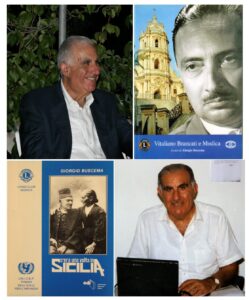di Giannino Ruzza
Può sembrare solo una formalità. Una lettera stampata su un passaporto: “M” per maschio, “F” per femmina… o “X” per chi non si riconosce in nessuna delle due categorie. Ma quella singola lettera è, per molte persone, una questione di riconoscimento e dignità. Nei giorni scorsi, una giudice federale negli Stati Uniti ha bloccato una norma dell’amministrazione Trump che voleva riportare indietro le lancette: imporre che il genere sul passaporto corrispondesse solo al sesso assegnato alla nascita. Punto. Senza eccezioni, senza possibilità di scegliere.
Un ritorno al passato (evitato in tempo)
La norma, parte dell’Ordine Esecutivo 14168, avrebbe cancellato l’opzione “X” per le persone non binarie o intersessuali. Una decisione che, nei fatti, negava la realtà vissuta da milioni di cittadini. La giudice Julia Kobick ha fermato tutto. Ha stabilito che quella norma è discriminatoria, e che non esiste alcun interesse pubblico che giustifichi una simile limitazione della libertà individuale. Ha ricordato che non si possono fare leggi basate sulla paura o sul rifiuto di ciò che non si conosce.
Perché ci riguarda tutti
Anche se questa vicenda si svolge negli Stati Uniti, il tema tocca anche noi. Perché ogni giorno ci confrontiamo con sistemi, moduli, burocrazie che danno per scontato che l’identità sia una casella da spuntare, non una realtà personale, mutevole e complessa. In Italia, il dibattito su genere, identità e documenti è ancora molto indietro. Ma leggere cosa accade altrove ci aiuta a capire che dietro ogni battaglia per il riconoscimento ci sono vite vere, non ideologie.
Il potere di un gesto semplice
Avere un documento che dice la verità su chi sei non è un privilegio. È un diritto. E negarlo, anche solo in nome della “normalità”, significa rendere invisibili intere comunità. Quando parliamo di diritti, pensiamo spesso alle grandi battaglie. Ma la libertà, a volte, si gioca su una singola lettera. Che può cambiare tutto.