
1. Le provocazioni del secolarismo
La fede cristiana, è fuor di dubbio, sta attraversando un momento difficile nella società e nella cultura contemporanea. Nel terzo millennio sembra quasi avvertirsi una emancipazione dal sacro, dal religioso e dai contenuti della fede cristiana. Mi chiedo: c’è ancora posto nella vita dell’uomo per la fede cristiana? Il messaggio cristiano può ancora dire qualcosa ad una cultura che ci tiene a dichiararsi laica e atea e che parla spesso di ingerenza della chiesa nella vita dello Stato? Di fronte a queste provocazioni, quali risposte la fede cristiana può dare?
La domanda è piuttosto complessa e richiede una risposta articolata.
Tutto è riconducibile ad alcuni concetti che è importante conoscere. Anzitutto il concetto di “secolarismo”. E’ un termine che viene da “saeculum”, cioè secolo, e che si oppone a sacro, religioso; un termine, insomma, che ha indotto alcuni a pensare in questo modo: l’uomo e le cose sono autonomi, non c’è nel mondo e nella storia alcun intervento soprannaturale. In pratica, si è verificato un mutamento di coscienza in base al quale il mondo non è più affidato a forze estranee all’uomo, non è più luogo di presenze divine, ma esso è unicamente affidato alla libertà umana ed ha il senso che l’uomo gli dà con la sua azione e il suo intervento.
Così, se nel passato un poeta come il Metastasio scriveva versi che dicevano: “ Dovunque il guardo io giro/immenso, Dio, Ti vedo…… “, oggi parole di questo tipo diventano insignificanti, perché per la coscienza secolare il mondo si va progressivamente razionalizzando, non nel senso che a tutto trova una spiegazione, ma nel senso che l’uomo, applicando la propria ragione alle cose, riesce a modificarle e a sottometterle. Il secondo concetto su cui voglio intrattenermi, riguarda il termine secolarizzazione, che a differenza del termine secolarismo, può avere, per certi aspetti, anche un significato positivo, poiché fa prendere coscienza, in quanto fenomeno culturale, del pluralismo esistente nella società e del fatto che la fede cristiana non è da concepirsi come una realtà totalitaria da cui far scaturire tutte le risposte per l’uomo contemporaneo. La secolarizzazione, dal punto di vista culturale, ha avuto certamente un suo progressivo sviluppo, del quale maggiormente oggi avvertiamo l’influenza.
2. La secolarizzazione e lo scollamento tra natura e Rivelazione
Come si è arrivati a questo processo di secolarizzazione? Che cosa ne ha preparato la strada? Quali fattori, in sostanza, hanno influito nel determinare l’affermarsi della secolarizzazione?
Un primo fattore è stato sicuramente lo scollamento tra natura e Rivelazione biblica. Quando il cristianesimo si diffuse nell’Occidente, per cui i popoli occidentali o con la forza o con le buone diventarono cristiani, il mondo intellettuale che lo accolse fu, anzitutto, il cosiddetto Platonismo, che consisteva nell’interpretazione del pensiero del filosofo Platone da parte di autori della primitiva era cristiana. E difatti, molti Padri della Chiesa fecero un’opzione per la concezione platonica, secondo la quale nell’uomo esiste un dualismo tra anima e corpo. Successivamente, quando comincia a diffondersi l’opera di un altro importane filosofo, qual è Aristotele, il pensiero cristiano ne viene condizionato, nel senso che la teologia comincia ad applicare alla Rivelazione biblica la dialettica filosofica del pensiero aristotelico.
Se prima tutte le varie discipline erano subordinate alla Rivelazione come nel pensiero medievale, dove tutto, dalla retorica alle lettere alla matematica, dalla geometria alla musica, confluiva nella lettura della Sacra Scrittura, con l’umanesimo e il rinascimento viene a delinearsi una visione autonoma delle varie discipline, tant’è che, ad esempio, Macchiavelli definisce l’autonomia della politica dalla fede, Galilei definisce il rapporto tra scienza e fede. Quest’ultimo proprio per aver letto la natura e l’universo indipendentemente dalla fede e dalla Rivelazione venne condannato dalla Chiesa.
3. Lo scollamento tra società e cristianesimo
Un altro fattore nel quale va ricercato il progressivo affermarsi della secolarizzazione è lo “scollamento tra società e cristianesimo”. Prima della Riforma luterana, il cristianesimo costituiva senz’altro l’elemento di riconoscimento universale nell’Occidente, cioè rappresentava l’unica religione socialmente valida per tutti. In base a tale riconoscimento la convivenza sociale trovava la sua giustificazione nei “principi religiosi” del cattolicesimo, per cui, ad esempio, il re veniva visto come autorità voluta da Dio per il bene comune, autorità nella quale tutti gli uomini si riconoscevano a livello sociale. L’avvento della Riforma protestante spezza l’unità religiosa e provoca uno scollamento tra società e cristianesimo. In pratica, il cattolicesimo cessa di essere l’unica religione socialmente valida per tutti, e così la coscienza moderna si accorge ad un certo punto che non ci si può riconoscere più nello stesso “fatto religioso” e, di conseguenza, anche la convivenza sociale non trova più la sua giustificazione nei “principi religiosi”.
In sostanza, gli uomini cominciano ad orientarsi, nel determinare la convivenza umana, verso principi e istanze basate non più sul cristianesimo, ma su “patti e principi” che gli uomini stessi si danno. Da qui, il secondo grosso scollamento di cui dicevo: non solo la natura si separa da Dio, ma anche la società si separa dal cristianesimo, che cessa di essere l’unico elemento di riconoscimento all’interno della stessa società.
4. La secolarizzazione e la separazione tra l’uomo e Dio
Infine, il terzo fattore alla base dell’affermarsi del processo di secolarizzazione è lo scollamento e la separazione tra l’uomo e Dio. Infatti, succede che vengono fuori alcune elaborazioni di pensiero che tentano di separare l’uomo da Dio. Sono soprattutto i cosiddetti “maestri del sospetto”, Feurbac, Marx e Freud, che mettono in discussione la fede cristiana attraverso una interpretazione del fatto religioso. E’ anzitutto il filosofo Feurbac a distruggere il fondamento del fatto religioso, affermando che la religione è una “proiezione dell’animo umano”, una creazione dell’uomo stesso, il quale proietta al di fuori di sé tutte le sue doti personali di bontà, di intelligenza, di amore, etc.., unificandole in un Dio immaginario, sicché quando adora Dio, non fa altro che adorare se stesso e le sue doti deificate. Questo spiega, allora, il senso di alcune affermazioni di Feurbac, quali “l’uomo nella religione ha come oggetto il suo proprio essere ignoto”; ogni fede “rende l’uomo limitato, gli toglie la libertà e la capacità di giudicare serenamente”.
A Ferurbac fa da eco un altro filosofo, Marx, autore di quella celebre frase: “la religione è l’oppio dei popoli”. In pratica, Marx interpreta la religione come un tranquillante di rassegnazione in quanto insegna a non ribellarsi ai mali sociali e perché svilisce la vita terrena sostenendo che essa non conta nulla, poiché l’unica vera vita è la vita eterna. Infine, con Freud viene ad affermarsi l’idea che la religione è una illusione. L’illusione, secondo lui, è un modo per non accettare la propria condizione nella società rispetto alla natura e agli altri uomini; la religione non ha nulla a che fare con la realtà, può essere vera o falsa, ma ci si aggrappa ad essa soltanto per superare eventuali disagi e condizionamenti. Ecco allora che non soltanto la natura si separa da Dio, non soltanto la società si separa dalla Rivelazione, ma anche l’uomo si separa da Dio. In questi tre fattori, dunque, vanno ricercati i presupposti dell’affermarsi del processo di secolarizzazione a partire dall’epoca moderna.
5. La secolarizzazione tra ideologia e fenomeno culturale
Se consideriamo la secolarizzazione come un processo o un fenomeno ideologico, allora non si può negare che essa sia da ritenere un fatto negativo per la fede; se, invece, la guardiamo come fenomeno culturale, possiamo coglierne anche il lato positivo. La secolarizzazione, non c’è dubbio, ha evitato l’assolutismo religioso, che vuole desumere dalla sola fede la risposta a tutti i problemi della vita pubblica e privata; ha aiutato la fede a guardarsi dalla tentazione di fuggire dalle responsabilità mondane, ha fatto prendere coscienza del pluralismo esistente all’interno della società, mettendo i cristiani nella prospettiva del dialogo e della collaborazione con gli uomini di altre fedi religiose e con tutti gli uomini di buona volontà.
La secolarizzazione, infine, ha esercitato una funzione purificatrice sulla fede dei credenti, nel senso che li ha obbligati a ripensare all’immagine che essi si fanno di Dio e della religione. Non c’è dubbio infatti che, oggi, molti cristiani hanno una visione di Dio del tutta erronea. C’è chi vede in Dio un “tappabuchi”, per usare l’espressione di Bonhoeffer, al quale ci si rivolge per intervenire in sostituzione del proprio impegno concreto; c’è chi vede in Dio un “custode” garante dell’ordine esistente, o un “rifugio” nelle occasioni difficili della vita, o, ancora chi lo considera un Dio “comprabile”, nel senso che i suoi favori dipendono da certe prestazioni umane e dalla buona condotta morale.
Ecco, rispetto a questi false immagini di Dio la secolarizzazione è spinge ad una nuova visione della fede cristiana di fronte alla complessa situazione culturale odierna. Quando invece la secolarizzazione si trasforma, come spesse volte è accaduto e accade, in indicazione ideologica, in secolarismo, rivendicando un’autonomia assoluta e contrapponendosi alla fede e alla religione al punto da negare radicalmente la dimensione trascendente e creaturale dell’uomo, allora essa non diventa altro che un proiettarsi in un assoluto antropocentrismo privo di quei riferimenti religiosi essenziali e determinanti per la realizzazione del senso della vita umana. In una parola, la secolarizzazione – direbbe Joseph Gevaert – diventa “l’indicazione di una ideologia anti-metafisica ed atea.”
Se, oggi, sovente si respira un clima di assenza di Dio e del trascendente, un laicismo che tende ad escludere tutto ciò che richiama l’uomo al pensiero di Dio, specie nella vita pubblica, è perché la secolarizzazione tende ad imporre una totale immersione nella terrestrità emarginando la fede come valore fondamentale dell’esistenza.













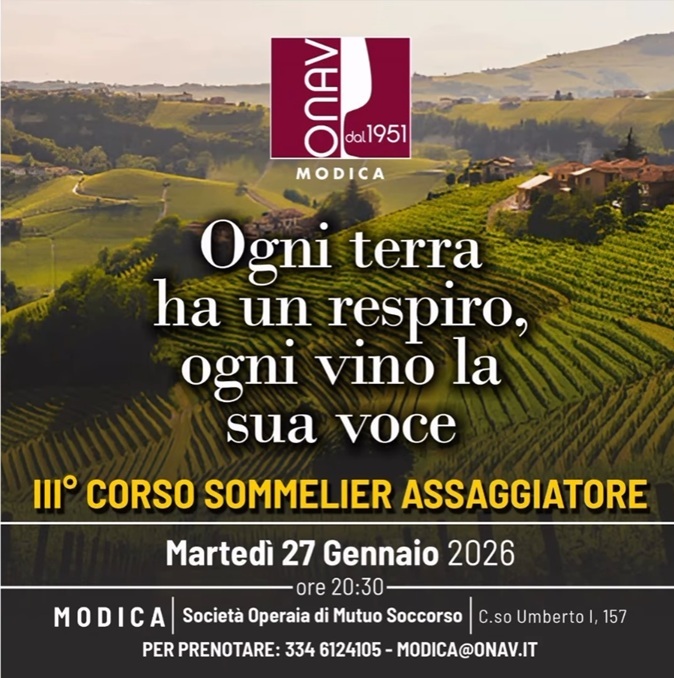


2 commenti su “Credere nel nostro tempo/4… di Domenico Pisana”
In sintesi stiamo entrando in un’altra epoca? In un futuro senza Dio? Potrebbe essere! Tutto ha un inizio e tutto ha una fine e prima o poi doveva succedere! Se cosi, stiamo vivendo troppi cambiamenti e troppo in fretta, talmente veloci che l’uomo non ha il tempo per metabolizzare e potrebbe anche disorientarsi, il che renderà tutto difficile e pericoloso. Anche da gestire.
Si sta per realizzare il sogno di qualcuno, di pochi eletti che si stanno preparando a governare il mondo. E questo loro sogno è iniziato! Un sogno che l’uomo non potrà più fermare perché troppo accecato e troppo distratto per guardare oltre il proprio naso, troppo preso dal suo quotidiano che si accorgerà solo quando tutto è compiuto. Troppo preso dall’avidità! Si diceva che doveva venire il nuovo Messia, ma stavolta credo che non lo faranno arrivare a 33 anni!
Saremo i nuovi schiavi, gli schiavi moderni! Non so quanto di fantasioso abbia scritto, ma è quello che penso osservando il mondo con distacco, ed è quello che vedo. L’uomo è nato con la natura, non può scomparire perché sostituito da macchine! È tutta qui la nostra intelligenza?
Eppure basta leggere l’infinito di Leopardi o baudelaire per comprendere che persino nella realtà materiale ci sono dei significati e delle profondità quasi speculari all’animo umano, che la ragione non comprende, figuriamoci la ragione materialista o scientifica.