
La prima scossa avvenne nella notte – “nell’ora quinta” – del 9 gennaio ma non furono in molti a sentirla perché i più dormivano e probabilmente a Lipari non dovette essere particolarmente forte. La seconda arrivò nel pomeriggio dell’11 gennaio, domenica, alle 13- 13,30 corrispondenti alle 21 siciliane dell’epoca, e questa volta la percepirono tutti, così riferiscono gli storici liparesi.
Ma prima di parlare di quali furono le reazioni dei liparesi, cerchiamo di capire , anche alla luce delle ricerche moderne, la natura di questo evento sismico.
“Il terremoto dell’11 gennaio 1693 in Sicilia orientale – osserva uno studio del dipartimento di fisica dell’Università di Bologna[3] – è l’evento di più elevata magnitudo[4] della storia sismica italiana. Ad esso fu associato un maremoto catastrofico, osservato lungo tutta la costa orientale della Sicilia e più a sud fino all’arcipelago maltese”. Questo terremoto ha provocato distruzione completa in molte città delle attuali province di Catania, Siracusa e Ragusa e gravi danni fino a Palermo e Messina . Lo tsunami che ha colpito l’intera costa ionica aveva onde fino ad 8 metri.[5]. I morti furono da 60 mila a 93.000[6]. A Catania morirono 16 mila persone su 20 mila abitanti che contava allora la città; 5 mila su 9.950 a Ragusa; 4 mila su 10 mila a Lentini; 4 mila su 15.339 a Siracusa. La prima scossa arrivò la sera del venerdì 9 gennaio alle 21 circa[7], crollarono numerosi edifici e vi furono vittime, altri edifici furono seriamente lesionati. Il sabato passò senza forti scosse mentre la mattina di domenica alle ore 9 si ebbe una forte scossa e un’altra circa un’ora dopo. Ma l’evento principale, la scossa di 7,4° Richter, arrivò alle 13 e 30 provocando l’immane distruzione e l’innesco del successivo maremoto. Lo sciame sismico con le scosse di assestamento, anche forti, si protrasse ancora per circa due anni con un numero elevatissimo di repliche. Ne vengono stimate circa 1500 di varia intensità e a volte, come quella dell’1 aprile, provocarono altri danni[8]. L’area di avvertibilità è stata molto vasta e si è estesa dalla costa africana alla Calabria settentrionale. “Il terremoto ha raggiunto un’intensità del 6° grado nelle isole Eolie, ed ha provocato danni abbastanza gravi nell’isola di Malta (8°), ma la parte più colpita è stata la Sicilia meridionale con un’area di circa 5600 kmq in cui il terremoto ha raggiunto un’intensità di almeno 9°”. L’area mesosismica, cioè quella dei massimi effetti, la cui intensità è stata valutata dell’11°, copre una superficie di circa 550 kmq e mostra una direzione di allungamento verso nord-est e verso sud-ovest, cioè verso Messina e Malta dove, in entrambe, il sisma è stato dell’8° e che sono poste rispettivamente ad una distanza di circa 180 e 110km dall’area dell’epicentro. Mentre sulla direttrice perpendicolare, si ha una forte attenuazione e l’8° è raggiunto fra i 20 e 40 km dall’epicentro. Questo spiega perché alle Eolie che si trovano proprio sulla direttrice verticale il sisma è stato di 6° ben due in meno di Messina[9].
Secondo le fonti il numero di vittime fu molto elevato:
- a Catania morirono 16.000 persone su una popolazione di circa 20.000;
- a Modica morirono 3.400 persone su una popolazione di 18.200;
- a Ragusa morirono circa 5.000 persone su 9.950;
- a Lentini con 4.000 vittime su 10.000 abitanti;
- ad Occhiolà (l’antica Grammichele) che contava 2.910 abitanti e ne perirono il 52%;
- a Siracusa con circa 4.000 vittime su 15.339 abitanti;
- a Militello con circa 3.000 vittime su una popolazione di quasi 10.000;
- a Mineo i morti furono 1.355 su 6.723 abitanti;
- a Licodia Eubea vi furono 258 vittime censite su una popolazione di circa 4.000 abitanti;
gli altri centri ebbero dal 15% al 35% di morti rispetto alla popolazione residente, più di 1.000 le vittime a Caltagirone, anch’essa in gran parte rasa al suolo, su una popolazione di circa 20.000 persone, tranne Palazzolo Acreide e Buscemi che lamentarono la scomparsa del 41% degli abitanti.[11]
Ma anche il Val Demona, a nord del Simeto, fu duramente colpito. Il De Burigny fa ascendere a circa duemila i morti ad Acireale,[12] su una popolazione che il Vigo stima in 12.000 abitanti.
Inestimabili furono i danni per il patrimonio artistico e culturale della parte orientale dell’isola. Il vescovo Francesco Fortezza riporta che dei 64 monasteri della diocesi di Siracusa solo i 3 di Butera, Mazzarino e Terranova erano in piedi, tutti gli altri erano stati distrutti.[13] Inoltre secondo una stima dei Senatori di Siracusa al Consiglio Supremo d’Italia a Madrid sono “rovinati e demoliti in tutto: 2 vescovadi, 700 chiese, 22 collegiate, 250 monasteri, 49 città e morte 93.000 persone.[14]
“All’unnici di Jinnaru a vintin’ura
a Jacu senza sonu s’abballava
cui sutta li petri e cui sutta li mura
a cui a misericordia chiamava”
“L’undici di gennaio alle ore ventuno
ad Acireale senza musica si ballava
chi sotto le pietre e chi sotto le mura
e chi invocava la misericordia divina”













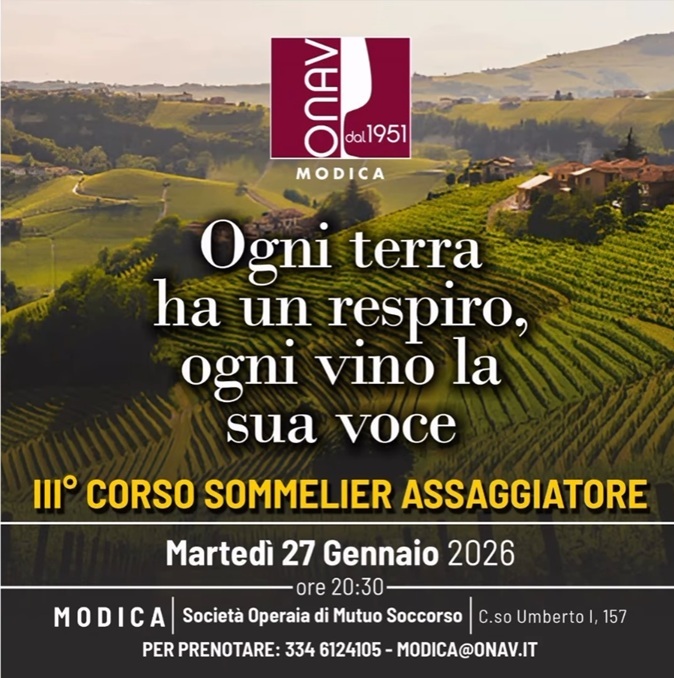


1 commento su “Il terremoto del 1693 nel Val di Noto”
I terremoti hanno memoria . . ritornano nei luoghi dove sono passati .
Spesso con la stessa energia con cui si sono manifestati .
Un evento simile , come si legge dalle relazioni volute dal fu papà Zamberletti (26 gen 2019), provocherebbe vittime e danni molto pesanti .
Si ipotizzano cifre tra il 30 % ed il 50 % dei residenti , con l’ evacuazioni delle popolazioni sopravvissute nell’arco di 5 giorni .
E come potete ben vedere le amministrazioni locali e non , dedicano ben poco attenzione nel giorno dello anniversario .
Anche perchè i terremoti hanno una cadenza periodica di circa 300 anni . . pertanto fate voi .
Perchè sono cadute nell’oblio le varie esercitazioni dedicate degli anni passati (1990 e successivi ) ?
Parlo delle S.O.T. , Sud-Orientali Terremoti .