
Credo non sia difficile ammettere che nell’opinione pubblica esistono molti pregiudizi, stereotipi e falsi clichés della donna. Ne risulta un’immagine deformata, offensiva della sua dignità personale, se è vero che a volte capita di sentir dire frasi come queste: “Ma perché cerchi lavoro, non lavora già tuo marito? Oppure: ma lascia stare la politica, la politica è cosa da uomini!
C’è , poi, oggi una visione pregiudiziale e lesiva della donna:
-c’è chi vede nella donna solo il sesso: di essa interessano soltanto le misure anatomiche e le capacità amatorie; è la donna-cosa, la donna strumento di piacere;
– c’è chi considera la donna un essere strano, eccentrico, imprevedibile, con il quale è difficile ragionare e di cui non ci può fidare;
– c’è chi senza mezze misure considera la donna inferiore all’uomo e per questo il suo posto è la casa, badare alle pulizie, alla cucina e ai figli.
Di questa mentalizzazione odierna, spesso si attribuiscono, erroneamente, responsabilità senza ragionamenti argomentati, alla cultura patriarcale, al mondo religioso, in particolare quello cristiano e musulmano.
1.La donna nella cultura cristiana tra Antico e Nuovo Testamento
Alcune correnti di pensiero hanno evidenziato che nella Bibbia sarebbe presente una concezione maschilista, in quanto la creazione dell’uomo e della donna non sarebbe avvenuta in contemporanea, ma anzi facendo derivare la donna dall’uomo.
Questa osservazione di maschilismo troverebbe poi un elemento di sostegno nell’affermazione del libro biblico di Genesi:
“non è bene che l’uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto simile a lui”(Gn 2,18), dove quel termine “aiuto” farebbe pensare ad una visione riduttiva della donna, quasi che fosse stata creata come semplice elemento accessorio all’uomo Adamo.
In realtà il senso biblico del termine ebraico “aiuto”(‘ezer) e ben diverso: esso non ha un significato “assistenziale” ma va inteso nel senso dell’ “essere alleati nel fare il bene”, ma anche di “forza” , atteso che “ezer” è da correlare all’ugaritico “gzr” che significa “forza”, per cui il termine nobiliterebbe di gran lunga la concezione della donna, considerata “la forza” dell’uomo.
Il termine “aiuto” usato da Genesi è poi da assimilare al significato che esso acquista nella letteratura sapienziale, e precisamente il significato di “colonna di appoggio” di cui si parla in Siracide 36,24-25, per cui l’aiuto è l’elemento di complementarietà maschile.
Anche sul significato dell’aggettivo “simile” c’è da fare qualche rilievo. Il testo ebraico usa il termine “ kene-gdo” che, letteralmente, significa “elevato, alto, visibile, che sta di fronte”, quasi ad indicare, prima ancora che l’antropologia culturale e l’etologia lo dimostrassero scientificamente, che l’uomo è l’unico animale che si accoppia “frontalmente”, cioè “guardando” la sua partner.
La donna, allora, è l’unico essere “eretto”, elevato in grado di stare “di fronte” all’uomo nell’atto della comunicazione sia verbale che sessuale.
Dunque la forza, l’aiuto, l’appoggio che l’uomo trova nella donna è tutto umano; non vi è nulla di sacro: non è un ezer divino che bisogna cercarvi, come era nei culti della religione cananea, ma un ezer kene-gdo, un appoggio corrispondente al livello umano dell’azione.
2.La creazione della donna
La Bibbia racconta che la donna è stata creata dalla costola di Adamo. Questa è una immagine che non va presa alla lettera e che apre una carrellata di interpretazioni: quelli che ignorano la corretta interpretazione teologica della Bibbia, prendono alla lettera l’affermazione secondo cui la donna è stata tratta dalla costola. In realtà, questa è invece una narrazione mitologica, dove il mito non è da intendersi come pura fantasia, ma come costruzione di immagini con cui si vogliono dire delle verità.
L’autore biblico per far comprendere ad Israele la creazione della donna , si serve, ispirato da Dio, e con un altro significato epurato da aspetti politeistici, del mito sumerico di Enki e Ninhursag, dove si racconta che Ninhursag per guarire il “mal di costole” della dea Enki , le partorisce la dea Ninti che, così, diventa la “dea della costola”. Ciò che è importante non è tanto il raffronto contenutistico tra il mito sumerico e il testo biblico, quanto il profilo linguistico. Il termine sumerico Ninti significa infatti sia “costola” che “vita”, il che spiegherebbe come la “signora della costola” dei sumeri sia diventata la “signora della vita” degli ebrei, oggi dei cristiani. Il simbolismo costola-vita è allora la chiave per interpretare la creazione di Eva, il cui nome significa “madre dei viventi”, e che può senz’altro equivalere a “signora della vita”.
Rimanendo sempre sotto il profilo linguistico, c’è ancora da dire che non è da escludere, come ipotesi, che possa essersi verificata una semplice storpiatura fonetica nella tradizione orale della Genesi: in pratica è ipotizzabile che il termine accadico tsilu(= vita) sia stato storpiato con l’ebraico tsela(=costola) che ha un suono simile. Sulla base di questa ipotesi linguistica il brano ordinario della creazione della donna indicherebbe allora che Eva è stata tratta “dalla vita di Adamo”. Se, da un lato, questo può avere un suo specifico valore teologico, dall’altra ha anche un significato simbolico, che tutt’oggi è presente nella espressione d’affetto e di amore: quante volte infatti si sente dire da parte di un uomo rivolto alla donna: “vita mia!”; o di una donna ad un uomo: “vita mia!”, o di una madre ad un figlio: “vita mia!”.
Il racconto della creazione della donna si conclude con l’affermazione “Il Signore la condusse all’uomo”: è, questo, l’ultimo atto di Dio. In questa fase del racconto nulla lascia intravedere una valutazione negativa della donna: la donna, nel pensiero di Dio, non è quell’essere diabolico, strumento di tentazione e di peccato, che per tanti secoli molta ascetica cristiana ha sottolineato con una certa ossessione; la donna è il partner che Dio dona all’altro, è – afferma la Bibbia in Genesi – il dono buono della creazione. Quando Dio conduce la donna all’uomo, questi esclama: “Allora l’uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tratta”.
La traduzione, in verità, non rende il senso di meraviglia, di stupore, di gioia provato da Adamo all’apparire di Eva; e difatti nella traduzione non c’è neanche un punto esclamativo. L’affermazione “osso delle mie ossa e carne della mia carne” ha un significato sociale, perché nell’Antico testamento viene usata parecchie volte, ma non è riferita al coniuge, ma ai membri della stessa famiglia (Gn 29,14; 2Sam 19,14), di uno stesso clan (Gdc 9,2), di una stessa tribù (2 Sam 19,13) dello stesso popolo di Israele, per cui quando Adamo si rivolge ad Eva con questa affermazione, il testo vuole evidenziare il valore del matrimonio come struttura sociale, in quanto la donna possiede l’elemento necessario a qualificarlo come tale.
Per quanto riguarda il termine utilizzato dalla Bibbia ebraica per indicare la donna, la parola usata è “issah”(donna), da cui deriva “is “ (uomo, letteralmente uoma); dal punto di vista filologico la radice di ‘is’(ws) indica essere forte, legarsi a qualcuno, mentre la radice di issah(‘ns) indica essere debole.
Alla luce di questa terminologia ebraica issah – ‘is, l’affermazione “La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tratta” non indica una situazione di inferiorità della donna rispetto all’uomo, ma, al contrario, una identità di natura tra uomo e donna e, quindi, una pari dignità, proprio perché nella mentalità ebraica il nome si identifica con la natura del nominato: la donna(issah) che è chiamata dall’uomo(‘is=uoma), è una attestazione, anche sul piano etimologico , della parità tra uomo e donna. In conclusione: che la donna sia stata tratta da una costola dell’uomo è una immagine mitica che vuole esprimere una verità che Dio ispira all’autore biblico: uomo e donna sono uguali e complementari, hanno la stessa natura, la stessa dignità e parità, quindi è da rigettare qualsiasi interpretazione del racconto della Genesi tendente a giustificare biblicamente l’inferiorità della donna rispetto all’uomo.
3. Il rapporto uomo-donna nel Nuovo Testamento: San Paolo
Alcune correnti laiciste hanno cercato di addossare delle responsabilità alla cultura cristiana affermando che San Paolo in fondo era un maschilista, tant’è che ha messo la donna in una situazione di inferiorità. Il testo di Paolo fortemente criticato è quello di Efesini 5, 22-23 ove si dice: “Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; il marito, infatti, è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. E come la chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto”.
L’errore che spesso si fa nel leggere questo testo è quello di affermare in maniera semplicistica che san Paolo quando scrive risente della mentalità del suo tempo, ove era diffusa una sottovalutazione della donna. E’ invece importante capire il senso del testo biblico nella sua profondità.
Si parla di “sottomissione” delle mogli, quindi delle donne; il termine sottomissione non va inteso in senso sociologico né gerarchico, ma in senso teologico, tant’è che San Paolo estende il termine “sottomissione” a tutti quelli, uomini e donne, che vivono nella comunità, nella ecclesia, affermando: “siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo” (Ef 5,21).
Il Dio dei cristiani rivelatosi in Gesù non intende dunque dire che il marito è “padrone” della moglie e che il patto interpersonale proprio del matrimonio è un patto di dominio del marito sulla moglie. Esprime, invece, un altro concetto: cioè che la moglie, nel suo rapporto con Cristo – il quale è per ambedue i coniugi unico Signore – può e deve trovare la motivazione di quel rapporto con il marito, che scaturisce dall’essenza stessa del matrimonio e della famiglia. Tale rapporto, tuttavia, non è sottomissione unilaterale, ma reciproca: il marito e la moglie sono infatti “sottomessi gli uni agli altri” e vivono la vita in due nella sottomissione a Cristo. La fonte di questa reciproca sottomissione sta nella “pietas” cristiana, e la sua espressione è l’amore. (cfr. Giovanni Paolo II, Udienza generale 11 agosto 1982)
Quando san Paolo afferma poi che Cristo è capo della Chiesa, cosa intende? Cristo non è capo perché comanda, dirige, detta ordini, perché è padrone della Chiesa, non è sicuramente così. Per Gesù essere capo ha significato servire, amare, nutrire la sua chiesa, prendersi cura fino al punto che ha dato la vita per essa con la morte in croce. Il verbo greco kefalaion indica la sommità, il vertice, il punto emergente, per cui Cristo è “kefalèè” cioè testa, capo, non in senso staticamente gerarchico, ma dinamicamente funzionale, nel senso che egli stesso ama e serve la Chiesa fino a morire per essa.
Chi tenta di utilizzare il testo biblico per finalità ideologiche fa una azione di scorrettezza; per la Bibbia, che, per chi è cristiano, è Parola Dio, l’essere capo della moglie non indica alcuna superiorità gerarchica ma la dimensione del dono: il marito cristiano, ad imitazione del Cristo, ama la moglie, la serve, se ne prende cura fino a morire per lei, come Cristo per la Chiesa. Stessa cosa vale per la moglie. Questo, per i cristiani, il pensiero di Dio di Gesù Cristo sull’uomo, sulla donna e sulla famiglia, e che il Magistero della Chiesa annuncia.
_______________________________
A.BARTH, Enciclopedia catechetica, seconda serie, 1959, Edizione Paoline.













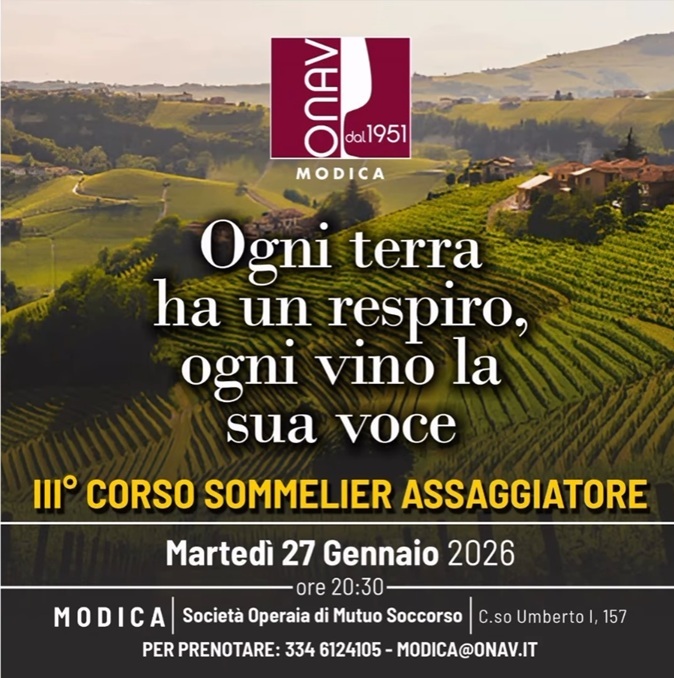


1 commento su “Lettura biblica della parità di genere…di Domenico Pisana”
È difficile pensare a un rapporto di dipendenza e sottomissione in una relazione di amore , complementarietà, sinergia , armonia e unità. Il problema è vivere ciascun membro secondo l essenza mascolina e femminina o la propria femminilità o mascolinità , senza pretendere in un malinteso senso di parità di essere come l ‘altro . La mascolinità e la femminilità in potenza devono dispiegarsi in atto secondo la loro naturale essenza, senza invadere l ‘altro campo di esplicazione e….ho detto tutto!