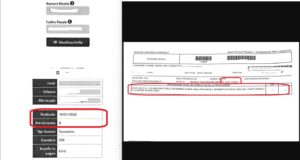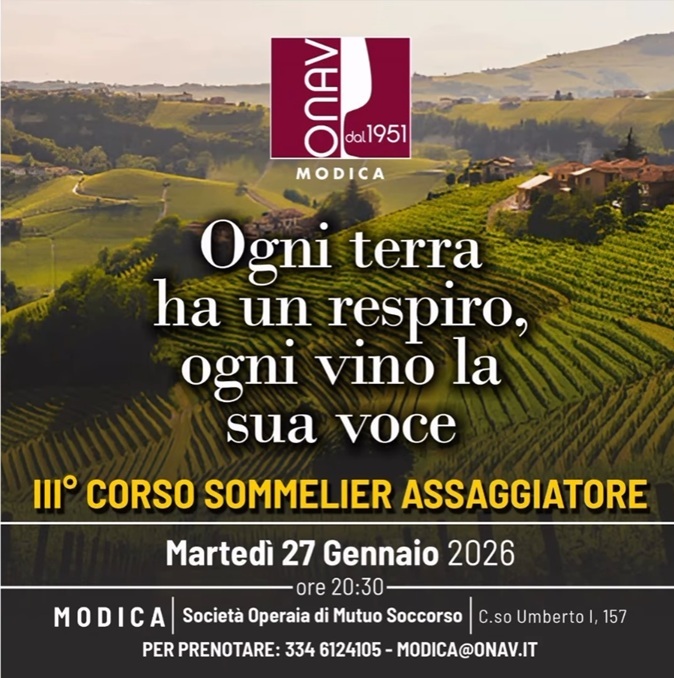Con il termine legislatura, si indica il periodo che va dalla prima riunione delle Camere al giorno del loro (normale) scioglimento. A partire dall’entrata in vigore della Carta Costituzionale, le legislature sono state contraddistinte dall’apposizione di un numero romano, con una numerazione progressiva crescente.
Il primo dei due commi che compongono l’art. 60 Cost. statuisce che: “la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni”, segnando un punto di rottura evidente non solo rispetto al sistema affermatosi durante il ventennio fascista, ma anche rispetto alle previsioni dello “Statuto Albertino”. Durante la vigenza della “Carta” del 1848, l’attività del Parlamento era organizzata in sessioni ed era segnata dalla previsione di poteri molto incisivi affidati al Re ed ai Ministri da lui nominati, sull’operato dell’unica Camera. La questione non migliorò durante il ventennio fascista, ove soppressa la “vecchia” Camera ed istituita quella dei Fasci e delle Corporazioni, i membri non venivano eletti, bensì ne facevano parte di diritto, in quanto componenti del Gran consiglio del fascismo o del Consiglio Nazionale del Partito Fascista o del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948, le cose cambiarono radicalmente e si preferì indicare un termine di durata per entrambe le assemblee (Camera e Senato). Fino al 1963, si volle provare con la differenziazione temporale tra le due Camere, difatti, mentre la Camera dei deputati durava in carica cinque anni, per il Senato della Repubblica era fissato un termine di sei anni. La differente durata si rivelò, peraltro, ben presto abbastanza disfunzionale alla vita dell’ordinamento e si volle adottare una soluzione più consona al bicameralismo perfetto, con l’eguale periodo stabilito in cinque anni ed eventualmente soggetto a scioglimento anticipato ad opera del Presidente della Repubblica (ex art. 88 Cost.).
Il secondo ed ultimo comma prevede: “la durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”. L’istituto della proroga, non va confuso con quello della prorogatio. Mentre quest’ultimo mira a garantire una continuità temporanea dei poteri delle “vecchie” Camere fino a quando non vengano riunite le “nuove”. La proroga risponde alla diversa esigenza di prolungare il mandato delle Camere oltre il limite temporale massimo ordinario unicamente nell’ipotesi eccezionale di guerra. La proroga, inoltre, è garantita da una riserva di legge, strumento cui tipicamente la Costituzione ricorre per assicurare che una determinazione sia preceduta da un adeguato dibattito pubblico e che venga assunta con il necessario coinvolgimento delle minoranze. Ci si chiede se per “in caso di guerra” debba intendersi un conflitto bellico a cui l’Italia partecipi o se si intenda come stato di guerra deliberato dalle Camere ai sensi dell’art. 78 Cost. e dichiarato dal Capo dello Stato ex art. 87 Cost.. L’opinione maggiormente prevalente propende per quest’ultima ipotesi, visto che le Camere stesse deliberano lo stato di guerra, conferendo al Governo i poteri necessari, e dunque proprio questi poteri, segneranno i confini delle attribuzioni e delle competenze delle Camere prorogate.