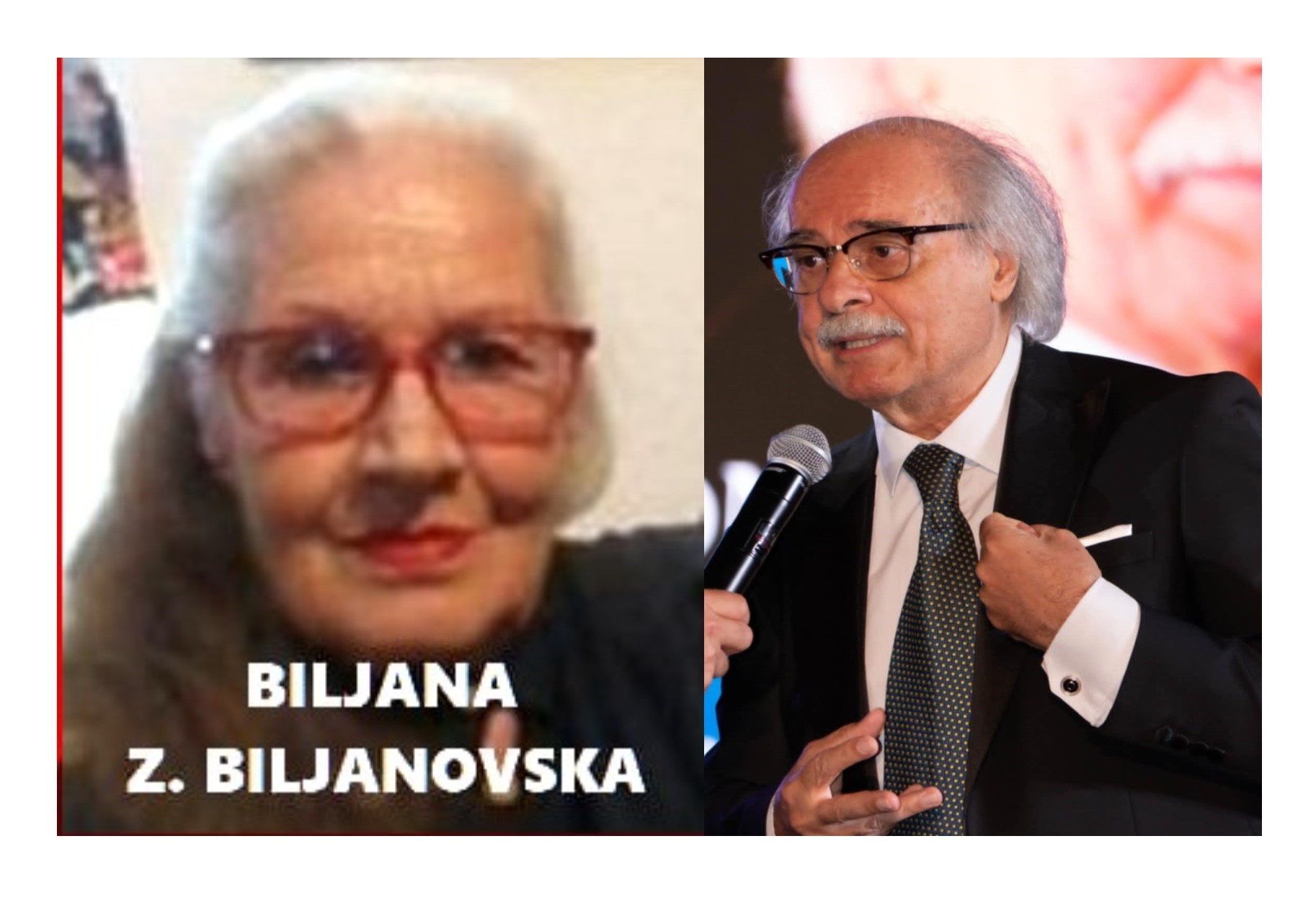
Parlare con un notevole professore, poeta, teologo, giornalista scrittore, autore di importantissimi volumi dedicati alla saggistica e alla crescita della critica letteraria, qual è Domenico Pisana, di Modica, Dottore in Teologia Morale, che ha frequentato l’Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Lateranense di Roma, fondatore e Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, è un fatto più che solo lodevole. Avere l’opinione, su questioni cruciali con cui ci stiamo incontrando innanzitutto in questi ultimi anni, di un personaggio così attivo ed influente nei circoli letterari dell’Europa contemporanea, forse dovrebbe dare alcuni risultati, esattamente nei tentativi che stiamo facendo per riconciliare l’intero mondo. Cioè, creare quei ponti dove la poesia e letteratura in genere possono contribuire ad allargare il dialogo, seminando i semi di un intendimento capace di migliorare le relazioni tra i popoli.
Domenico Pisana ha pubblicato 11 libri di poesie, 12 testi di critica letteraria; 13 testi di carattere etico – teologico, 3 volumi di carattere storico-politico. E’ stato ospite in importanti Festival Internazionali (Bosnia, Istanbul, Madrid, Matera, Zacinto in Grecia, Firenze, Milano), e sue opere sono tradotte in inglese, francese, spagnolo, turco, rumeno, polacco, russo, macedone, albanese , serbo, arabo. Ha intrapreso rapporti con il mondo arabo e l’Egitto ove di recente è stato ospite dell’Università Badr in Cairo come relatore e per la presentazione di due suoi libri. Tra i sui oltre 40 premi nazionali e internazionali e riconoscimenti si segnalano: Medaglia d’oro del “Premio alla Modicanità”,2006; Medaglia d’oro alla carriera, ricevuta dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi, 2022; Premio letterario alla cultura “Naji Naaman”, ricevuto in Libano, 2021; Premio “Roma Award of Outstanding Personality”, ricevuto a Zacinto in Grecia il 28 agosto 2023; Premio alla cultura ricevuto il 22 febbraio 2024 dalla Provincia Regionale di Ragusa e Comune di Ragusa; Riconoscimento di Accademico ad honorem dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari, 19 ottobre 2024, Premio ”Ragusani nel mondo, 27 agosto 2025
.
B.Z.B.: Avendo questa immagine abbastanza completa, ma mai sufficiente, di Lei, Stimatissimo professore Pisana, secondo la mia cognizione dei fatti sopra elencati e sulla base della nostra approfondita collaborazione negli ultimi anni, sono dell’opinione che in un dibattito aperto e sincero si possa determinare la creazione di un spazio dove la sua parola di poeta e scrittore possa diventare un modus vivendi; le chiedo pertanto: in quale e quanta misura noi tutti possiamo influire nella costruzione del mondo con le nostre parole, nonché nella crescita e costruzione di un’ umanità più sostanziale e accogliente?
D.P.: Io credo che l’intellettuale, il poeta e lo scrittore non hanno il potere diretto di cambiare il mondo con un singolo gesto, ma possono avere la capacità di seminare semi di pensiero, critica ed empatia, che, nel tempo, possono germogliare e trasformare profondamente la società e le persone. L’influenza degli uomini di cultura è tanto più efficace quanto più le loro parole sono testimonianze di vita e riescono a stimolare il dialogo e a innescare una riflessione collettiva.
Gli scrittori devono agire come fari critici e catalizzatori di cambiamento; essi, infatti, attraverso le loro parole analizzano il presente, denunciano le ingiustizie e propongono visioni alternative. La nostra azione può influenzare la costruzione del mondo in vari modi: con la formazione dell’opinione pubblica, favorendo analisi ed esempi che possono animare il dibattito pubblico, spingendo le persone a riflettere su questioni sociali, politiche ed etiche.
Le parole dei poeti, degli artisti, dei filosofi e dei teologi contribuiscono a creare, a mio parere, nuove idee e paradigmi, a custodire la memoria collettiva promuovendo l’empatia e la comprensione , incoraggiando la riflessione etica sui valori che guidano le nostre azioni e la nostra società e contribuendo a formare cittadini più consapevoli e responsabili, dando voce a chi non ha voce e portando alla luce problemi e ingiustizie che altrimenti rimarrebbero nell’ombra.
B.Z.B: Secondo la sua esperienza e le informazioni non molto consolanti che ultimamente arrivano dai due punti focali che hanno completamente disturbato l’equilibrio del mondo intero, in quale e quanta misura la letteratura contemporanea, prima di tutto la poesia con cui ci stiamo consolando noi poeti del mondo sempre con l’idea che scrivendo in un certo modo stiamo contribuendo al miglioramento dei rapporti tra le diverse culture e popoli, può essere in grado di dare risultati che saranno positivi in ogni senso della parola? Rimarranno solo testimonianze per le generazioni future, per nostri figli e nipoti, del fatto che anche noi, generazioni di questo evo, abbiamo fatto il possibile per la crescita di una Umanità più accogliente e migliore?
D.P.: La letteratura e la poesia, specialmente in questi tempi difficili, non offrono una soluzione rapida o un rimedio immediato ai problemi geopolitici. Non fermeranno le guerre, non risolveranno le crisi economiche e non faranno cessare gli odi. Né, del resto, è compito della poesia e della letteratura. La loro forza, a mio avviso, risiede altrove. Attraverso la letteratura, la narrativa e le poesie, possiamo entrare in contatto con le esperienze e le emozioni di persone che vivono in contesti molto diversi dai nostri. Leggendo, per esempio, le vicende di un soldato, di un rifugiato, o di una madre che ha perso il suo bambino, la nostra percezione del “nemico” o “dell’altro” può cambiare radicalmente. La letteratura abbatte le barriere dell’anonimato e spesso ci costringe a vedere l’umanità dietro i titoli dei giornali.
La poesia, in particolare, con la sua intensità e immediatezza, riesce a catturare l’essenza di un dolore, di una speranza, di una protesta in modi che la prosa, a volte, non può. Con i loro versi, poeti di culture diverse possono comunicare le loro verità, le loro tradizioni e le loro sofferenze, creando un ponte emotivo tra i popoli. La letteratura ha il potere di lasciare testimonianze, atteso che le opere contemporanee che nascono in risposta alle crisi attuali, diventeranno, nel tempo, parte della memoria storica, esperienze di vita non solo di fatti, ma anche di sentimenti e di esperienze umane, e serviranno alle generazioni future per comprendere il presente e, forse, evitare gli stessi errori.
Il valore della letteratura contemporanea e della poesia non sta per me nel successo, ma nella capacità di mantenere viva la conversazione, di nutrire la speranza e di ricordare l’umanità che ci accomuna. Ogni verso che esprime compassione, ogni storia che promuove la comprensione, è un piccolo ma significativo passo verso un mondo più accogliente. È un’azione di resistenza contro la banalizzazione del male e contro la perdita di sensibilità.
In conclusione, per me la letteratura e la poesia non sono strumenti di azione politica diretta, ma sono strumenti di trasformazione interiore e culturale. La loro efficacia risiede nel loro potere di entrare nel cuore e nella mente delle persone, ponendo le basi per un dialogo autentico e per una convivenza più pacifica nel futuro.
B.Z.B.: C’è un fatto molto inquietante con cui c’incontriamo ultimamente, e che quasi si sovrappone mentre le pongo la seguente domanda: Non solo tra la gente di una città o paese, ma, in genere, tra i popoli dell’ Europa contemporanea e del mondo intero, “leggere”, per molti, sta diventando una fatica o lusso, o semplicemente mancanza del tempo a causa dell’ intera modernizzazione della vita. Secondo Lei, in quale modo possiamo creare nuove matrici per tentare di aprire l’interesse tra la gente al fine di rinnovare quella antica curiosità verso la lettura? Cosa pensa si possa fare , esattamente come avveniva per noi una volta, per far nascere un maggiore interesse per la scoperta di nuovi autori, per alimentare bisogni con nuovi contenuti, far scoprire nuovi ambienti, e non solo locali, ma internazionali?
D.P.: La diminuzione dell’interesse per la lettura è una sfida complessa, causata dalla modernizzazione e dalla concorrenza di innumerevoli stimoli digitali. Per rinnovare quella “antica curiosità” di cui lei parla, non basta promuovere i libri, ma bisogna ripensare il modo in cui la lettura si inserisce nella vita delle persone.
Credo che si possano creare nuove matrici attraverso un approccio che sia al contempo tecnologico e sociale. In breve, secondo me per riaccendere la curiosità verso la lettura, dobbiamo abbattere le barriere del tempo e dell’impegno, e dimostrare che leggere può essere un’esperienza moderna, personalizzata e socialmente gratificante. Si tratta di trasformare la lettura da un “dovere” a un “piacere” che si integra perfettamente con la vita frenetica di oggi.
B.Z.B.: Con l’ intera sua esperienza pedagogica, professore Pisana, avrebbe qualche consiglio o raccomandazione da fare circa il modo di porsi di fronte ad una vita che talvolta ci lascia senza parole, e ci prende il fiato? Può darci un consiglio, che tra i nostri lettori, volente/nolente, possa rimanere a ricordare cosa vale, o cosa non vale fare, o perdere tempo? Ormai sappiamo benissimo che nessuno è riuscito a mutare il ritmo della vita dell’Universo, eppure con tutti questi esperimenti eseguiti da parte delle grandi potenze si rischia di perdere molto della vera natura dell’Universo planetario. Lei non crede che con tutti i cambiamenti climatici, occorra educare il comportamento della gente perché si comprenda il vero valore dell’ambiente, quale parte integrante della natura del Pianeta Terra?
D.P.: Il primo consiglio che mi sento di dare è quello di riscoprire il proprio mondo interiore, spesso soffocato dalla frenesia del mondo consumistico contemporaneo, staccando, ogni giorno, la spina dal rumore esterno. Da credente in Gesù Cristo, dico che la meditazione spirituale, anche per pochi minuti, mi aiuta a concentrarmi sul respiro e a riportare la mente al momento presente, riducendo l’ansia e la sensazione di essere sopraffatti. Concedersi brevi spazi di tempo all’aria aperta, anche solo in un parco cittadino, o sul balcone della propria abitazione, è un modo potente per riconnettersi con i ritmi naturali del pianeta. Questo contatto mi aiuta a ridimensionare le preoccupazioni quotidiane e a ricordare che faccio parte di qualcosa di più grande.
E’ vero, viviamo in un’epoca di sovraccarico informativo, per cui saper distinguere ciò che è davvero importante da ciò che è una distrazione, è cruciale ed estremamente necessario. Per me le relazioni umane, autentiche e significative, sono la vera ricchezza, perché ti fanno stare bene e contrastano la solitudine e il senso di alienazione che la tecnologia a volte può creare. Ho imparato a proteggere il mio tempo e a dedicarlo a ciò che conta davvero, e tra le cose che contano c’è anche la preghiera che, come cristiano, sento non come un dovere ma come una necessità.
Dalla preghiera e dal mio rapporto con Dio, deriva il mio impegno ad aiutare il fratello e coloro che hanno bisogno, indipendentemente dalla nazionalità e fede religiosa; dal mio credo cristiano deriva l’impegno ad agire con responsabilità, a fare scelte quotidiane che rispettino l’ambiente così da contribuire attivamente, nel mio piccolo, al benessere del pianeta, superando il senso di impotenza. Io credo che il cambiamento inizia da noi stessi, da piccole azioni individuali che, sommate, creano un impatto significativo.
Sono convinto che il segreto per navigare nella vita contemporanea non è cercare di controllare l’incontrollabile, ma ritrovare il controllo su se stessi, sulle proprie scelte e sulle proprie azioni. Chiudo, ricordando a me stesso: ciò che ti fa sentire vivo, è ciò che contribuisce, anche in minima parte, a un mondo migliore. Tutto il resto è tempo perso.
Biljana Z. Biljanovska
Skopje, Repubblica Macedonia del Nord, scrittrice, saggista, giornalista indipendente, poetessa, interprete professionale (francese, italiano, macedone, serbo)























2 commenti su “Poesia e spiritualità per un nuovo umanesimo…di Biljana Z. Biljanovska”
Umanità , si dovrebbe indagare e riflettere a fondo su questa parola ; la parola che fa si che quello che ci differenzia è solo la superficie , la facciata. Siamo venuti in questo mondo dove abbiamo un destino mortale , la vita nasce mentre muore ossia il presente diventa passato per far posto a un altro presente , nonostante ciò cerchiamo appigli nella vita del tempo, anche la ricerca assidua di come significare il momento può significare avidità e tentativo inane e inutile di eternizzare e rendere stabile la vita nel tempo , che invece è viaggio verso un altrove . Ma nonostante i malintesi nella ricerca del giusto cammino resta che una ricerca resta e una domanda sulla ricerca stessa. Spirito e corpo designano e spiegano l ‘essere uomini . Non penso esista o possa esistere una vecchia umanità e una nuova , esiste l ‘umanità e basta e lo spirito la connota , ma anche la conoscenza che si fa cultura, che parte dall ‘umanità e a essa ritorna per accrescerla . La poesia e tutta la letteratura sono umanità che parla all ‘umanità per accrescerla, più o meno indirettamente dicono agli uomini che il male opprime e l ‘amore eroico libera , che la guerra e per quelli della clava e della fionda , le guerre , i profitti miliardari sono il risultato di una degenerazione istintiva e animalesca dell ‘umanità , non dovrebbero rientrare nel concetto, ma anche le divisioni , tutti i patriottismi egoistici e divisori, la patria dell ‘umanità è il mondo , necessita un governo mondiale , una costituzione per l umanità, per la pace e la libertà, il resto è archeologia e inciviltà.
Ahahaha!!!! Caro ispettore ,ahahaha !!!! Ma cosa dice , il suo commento è un fritto misto di disconnessioni assurde , ma cosa centra? Il suo ragionamento è simile ai ragionamenti che si fanno in preda ai fumi dell ‘alcol o poco prima di dormire , ha divorato troppi libri di filosofia e gli andato di volta il cervello, ahahaha !! Si faccia controllare , sempre in cerca di gloria commentando Pisana ma ottenendo solo gogna universale ahahaha , come l ‘occhio nero ⚫️ cercando un fantastico pedofilo che esiste solo nella sua mente degenerata. Ahahaha