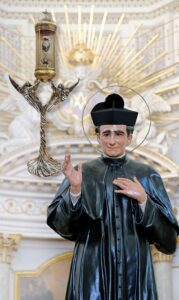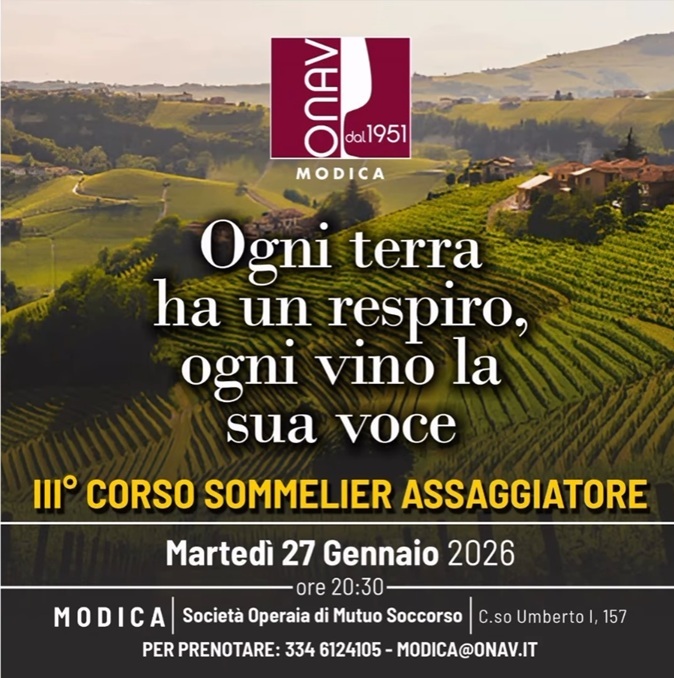Di questa si occupa l’art. 29 Cost.. Tale articolo è il primo del Titolo II, dedicato ai “Rapporti Etico-Sociali”, della “Parte Prima”.
Gli obblighi delle istituzioni statali sono profondamente cambiati nel trapasso dallo Stato liberale allo Stato sociale. Nel momento in cui l’industrializzazione ha modificato l’assetto sociale è stata, infatti, essenziale una ingerenza da parte dello Stato a sostegno dei soggetti economicamente e socialmente più deboli, onde garantire piena attuazione al principio di uguaglianza sostanziale, previsto dall’art. 3 Cost.. Sono stati pertanto riconosciuti i diritti sociali, destinati a garantire i bisogni minimi vitali necessari ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa e riconosciuti all’uomo in qualità di membro di una formazione sociale (art. 2 Cost.).
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, è quanto previsto dal primo comma, dell’art. 29 Cost., e sta a significare che la famiglia è il nucleo in cui l’essere umano si forma e sviluppa i suoi diritti inviolabili. Con la definizione di “società naturale” i “Padri Costituenti” hanno inteso precisare che essa preesiste allo Stato e non deriva da esso, anche se, facendo riferimento all’istituto giuridico del matrimonio, è come se vi fosse una vera e propria contraddizione, dato che il matrimonio è un negozio giuridico e come tale un atto tecnico e formale e per questo disciplinato dallo Stato. Con il passare degli anni e visto il vuoto di tutela, si è sentita la necessità di fornire una regolarizzazione non solo le famiglie di fatto (quelle in cui due soggetti di sesso diverso, convivono stabilmente), ma anche le coppie omosessuali (legge n. 76/2016); riconosciute e tutelate non dall’art. 29 Cost. bensì alla stregua di formazione sociale di cui all’art. 2 Cost..
Il secondo comma, dell’articolo in questione, statuisce che: “il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Sulla base dell’uguaglianza dei coniugi, grazie, prima, ai numerosi interventi della Corte costituzionale, e, successivamente, grazie all’intervento del legislatore, si è arrivati all’eliminazione delle disparità di trattamento esistenti, sia in materia penale (si pensi al diverso trattamento sanzionatorio del reato di adulterio commesso dalla moglie, rispetto a quello commesso dal marito), sia in materia civile. Viene perciò associata alla donna una posizione che nulla ha più a che vedere con la situazione precedente, tutta incentrata sull’istituto della potestà maritale, che riservava al marito un ruolo di assoluta preminenza all’interno della famiglia.
La postilla di chiusura del comma secondo, dell’articolo 29, cioè “…con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”, è una sorta di clausola di salvaguardia richiesta da chi voleva proteggere la possibilità di un dissimile trattamento in presenza di esigenze particolari. L’esempio classico si riferisce al caso che in eventuali contrasti tra i genitori in merito alle scelte sui figli, il giudice, dopo aver tentato una soluzione bonaria tra i due, doveva adottare la decisione paterna; tutto questo oggi è stato sostituito con la soluzione più conforme all’interesse del figlio stesso.