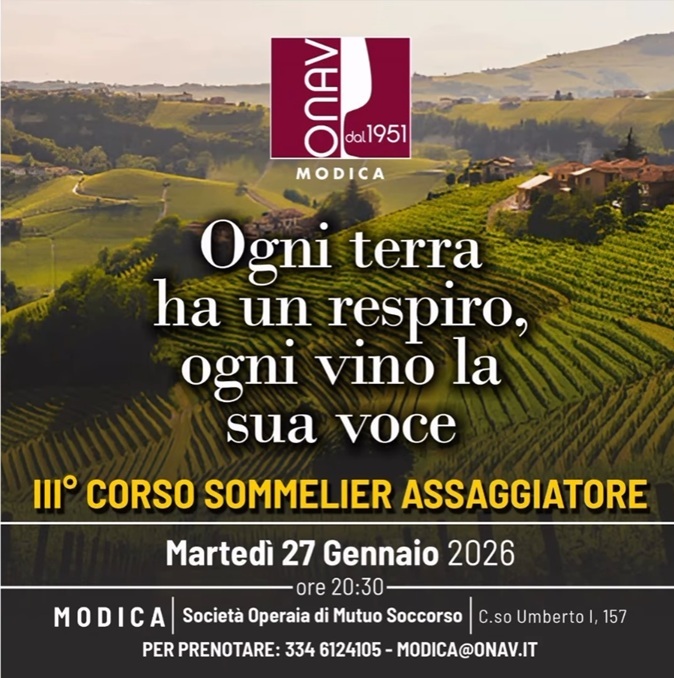L’itinerario poetico che caratterizza la silloge di Sofia Skleida ed Elisabetta Bagli, dal titolo Dal Mediterraneo, ci apre orizzonti di ampio respiro ove il mare Mediterraneo diventa il background sostanziale di riferimento, lo sfondo storico, ambientale e culturale, il contesto dentro cui si muove tutta la versificazione dell’opera; la stessa preposizione articolata “Dal”, è paradigmatica sul piano della struttura teleologica della raccolta , perché indica il punto locativo di osservazione e di incontro di due esperienze poetiche che si incrociano e si edificano , si uniscono e si diversificano, facendosi testimonianza di un cammino spirituale e culturale in dinamico divenire.
Se pensiamo al Mediterraneo come al “Mare Nostrum” , al mare considerato primo, unico e culla della civiltà e della storia, al mare che ha ispirato Omero e Virgilio, per i quali esso non era un semplice sfondo paesaggistico, ma luogo delle partenze e dei ritorni, luogo del movimento e dei passaggi, delle lotte e delle conquiste, delle fughe e della ricerca di un punto d’arrivo, i testi poetici di questo volume ci fanno incrociare e respirare la storia, gli odori, i valori, i sapori e la cultura di luoghi che le due poetesse, una italo – spagnola, l’altra greca, trasfigurano nella loro declinazione sulla pagina.
E questo appare subito evidente già nelle liriche di apertura, ove Sofia Skleida colloca se stessa nello spazio dei “vicoli della Plaka” in compagnia di Pericle, Fidia, Iktinos e Mnesicles, mentre Elisabetta Bagli si sorprende nella ricerca delle sue radici intenta a vagare verso il Pantheon:
“Per i vicoli della Plaka
mi portano di nuovo i miei passi.
Mi conducono Pericle,
Fidia, Iktinos, Mnesicles.
Confluiscono i miei passi,
sospesi sulla Storia di Roma,
vagando verso il Pantheon,
nel Rione della Pigna,
cercando me stessa, le mie radici…”
(Skleida-Bagli, “Dal Mediterraneo: storia”)
L’incipit della silloge è, insomma, un richiamo alle origini di due civiltà che “Sono l’Anima del Mondo”, una rivisitazione memoriale ove ritmicamente “convergono in unum” le emozioni, i sentimenti e le conoscenze delle due poetesse, nonché “i ricordi del passato”, “Ricordi vivi di quel che fu”, “tradizioni, miti e leggende”, “Colonne sul palco / Cariatidi che hanno adorato Dio” e “Colonne d’ogni epoca” divenute storia e bellezza per visitatori e turisti; ed ancora “Foto magiche / di religione , di culto” e “Istantanee ingiallite e impolverate”.
1.L’incontro di radici culturali e valoriali
Il corpus della silloge poggia sull’ “ermeneutica della vita” delle due autrici, le quali rimarcano le loro comuni radici culturali; se, infatti, Skleida canta il “comune destino / che è apparso sotto lo stesso cielo stellato” e “la sete per la vita”, Bagli innalza la sua supplica al Signore affinché possa donarle di camminare sui luoghi della sua infanzia, di “tornare a calpestare la sua terra e intonare canti (…)sui generosi colli della Conca d’oro di Palermo”: “…supplico il Signore / di aiutarmi a tornare a casa / e posare i miei piedi di donna / sulla terra della mia infanzia. /Lo supplico di darmi / mani nude per scrivere / sul libro bianco della mia vita, / di darmi braccia per cullare / l’alba del nostro Mediterraneo / e di portarla nei tuoi occhi”, (da: “Supplica”).
C’è in questo canto a due voci l’abbandono alla memoria storica, al gusto delle sensazioni e delle emozioni fresche e genuine riflesse e ritrovate nella storia greco-latina e nel fascino del Mediterraneo, topos non solo su piano storico e politico ma soprattutto etico, estetico e letterario.
Sofia Skleida ed Elisabetta Bagli aprono, con i loro versi, uno scenario nuovo, perché tendono ad evidenziare che il Mediterraneo non è solo mare amaro e che mette paura, solo fatica e insicurezza, morte e guerra, luogo dal quale sono venute ieri le minacce esterne, ma è anche “una categoria dello spirito”, è la parabola di un “sentimento” che parte dai loro cuori per farsi comunicazione e per estendersi come essenza intima dell’ essere; è una metafora dentro la quale scorrono le tracce dei destini che i popoli ci hanno lasciato.
E’ tutto questo le due autrici lo testimoniano, in modo incisivo , attraverso testi che si integrano nell’unità di un discorso poetico nel quale risalta – come accade nei versi di Skleida – ora il richiamo alla civiltà giuridica con il riferimento alle “Novellae Constitutiones” o “Nuove Leggi” radicate nella quarta e ultima parte del lavoro legislativo di Giustiniano,( Si legga la lirica “Ode”); ora il richiamo all’ “Inno alla Gioia”, scritto nel 1785 dal tedesco Friedrich Schiller e musicato da Ludwig van Beethoven nel 1824, poi adottato, nel 1972, come inno del Consiglio Europeo(Si legga la lirica “Speranza”); ora il riferimento a Pausania che riporta la legge degli Elei , la quale vietava alle donne di entrare nel luogo della celebrazione dei Giochi Olimpici, legge che venne violata da Kallipateira o Fereniki (Si legga la lirica “Saccenti”).
Lo stesso inabissamento nella civiltà del Mediterraneo trasuda dai versi di Elisabetta Bagli, la quale viaggia tra le atmosfere di una civiltà legata al sentimento della memoria, alla cultura popolare, ai valori dell’appartenenza e dell’integrazione, al concetto di mare e di luoghi. E tale viaggio interiore, la Bagli, lo vive ispirandosi al mito greco-romano esposto nelle Metamorfosi di Ovidio, poeta romano di Sulmona, e richiamando la giovane ninfa Clizia innamorata del Sole, che seguiva con lo sguardo durante tutto il giorno mentre conduceva il suo carro di fuoco per l’arco celeste(Si legga la poesia “L’eterno girasole”); lo incarna ispirandosi a “Le Parcae” (Le Parche) della mitologia romana, corrispondenti alle Moire greche, che venivano raffigurate nell’arte e nella poesia come vecchie tessitrici scorbutiche o come oscure fanciulle con la funzione di stabilire il destino degli uomini (Si legga la poesia “ Prima emozione”); lo costruisce ricollegandosi all’eccidio delle Fosse Ardeatine che vide l’uccisione di 335 civili e militari italiani, trucidati a Roma il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione tedesche(Si legga la poesia “Sull’Ardeatina”), nonché all’olocausto ebreo (Si legga la poesia “Ricordi civili”).
2.Le migrazioni in un teatro di assurde contraddizioni
Sofia Skleida ed Elisabetta Bagli sono insomma due voci poetiche che propongono al lettore il rapporto tra “Mediterraneo, storia e letteratura”, un rapporto che posa lo sguardo non solo sul passato ma anche sulla contemporaneità, specialmente sul fenomeno delle migrazioni, fenomeno che ha rimesso in discussione il significato di confini politici troppo facilmente considerati acquisiti, e che si è riproposto in tutta la sua complessa drammaticità suscitando il confronto culturale con altre culture e determinando la necessità di una “ri-comprensione” del tradizionale ruolo dello stato nazionale.
Emblematiche, a riguardo, le poesie “Profughi” e “Le barche della speranza”, due testi fortemente impregnati di pathos e guidati da una dolente riflessione sul dramma dei migranti salvati, nonché dal dolore per quel consistente numero di morti che ha trasformato il Mediterraneo in un cimitero.
Sofia Skleida stigmatizzando la contraddittorietà di un mondo “avvolto nel teatro dell’assurdo”, eleva al cielo il suo pianto al vedere corpi che combattono contro le onde della morte, occhi innocenti che pagano l’orrore delle guerre (“Corpi tremanti vagano ovunque … / carichi di tristezza e di tragedia / in un disuguale combattimento con la morte / in carrette di mare, in carri scuri / maleodoranti d‘abbandono e disperazione. / Vorresti parlare, piangere, correre, nasconderti / ma da chi, da che cosa, / non lo sai …”(da: “Profughi).
La voce trepidante di Skleida si intreccia con quella di Elisabetta Bagli, che disegna le coordinate di un meccanismo di morte che vede “spietati aguzzini” e “sporchi padroni” vendere sogni di terra promessa ammassando “come bestie” uomini, donne e bambini “su legni galleggianti e rotti” che non giungeranno mai a destinazione:
“Sono le barche della speranza
quelle che solcano i mari
nella persistente penombra
di chi, disperato, crede nel sole,
mentre il vento nudo
lo sorprenderà nella notte,
quando gli specchi della terra
spegneranno per sempre
gli aneliti luminosi della luna.
Vendono tutto
agli spietati aguzzini,
agli sporchi padroni
del loro destino…”
(Elisabetta Bagli, “Le barche della speranza”)
Le due poetesse danno, così, voce non solo al dramma dei migranti, ma anche al grido di dolore causato sia dalla presenza del male nel mondo, sia dalle calamità naturali, come nel caso del terremoto avvenuto in Italia e che ha colpito la città di Amatrice: l’anima greca di Skleida vede i “Tantissimi i mali del mondo”, e ritiene che
“…tutto potrebbe essere tollerato
se tutti potessimo vedere la luce
lontana, ma desiderata
se tutti potessimo sentire la gioia,
lontani da ogni tristezza
se potessimo offrire l’amore lodevole tessuto nell’arcolaio
e riempire di baci tutto il mondo…”
( Sofia Skleida,“Rifletti”)
Le fa eco Elisabetta Bagli, la quale trasfigura con la parola poetica il male causato dal sisma, il dolore dei terremotati che si eleva nella notte: “…Nel buio più profondo /cullando i nomi nelle lacrime,/ nelle ferite amare di chi sa / di aver perso tutto, ma non amore e dignità…”(Da: “L’inferno senza colpe”).
Dal Mediterraneo è una raccolta dai lineamenti limpidi, essenziali, mai ridotti a spazi di edulcorate alchimie, ma sempre mossa da intenti lirici e necessitata dal bisogno delle autrici di dare forma e sostanza a quelle ispirazioni che sopraggiungono nella mente e nel cuore. Si leggano, ad esempio, le poesie “Che fece… Il Gran debutto” e “Miracolo sotto il sole”. La prima , di Sofia Skleida, parafrasa il titolo della poesia di Kavafis “Che fece…Il Gran Rifiuto”, e in essa l’autrice inneggia alla figura di questo grande poeta greco nato nel 1863 e morto nel 1993, con parole che ne esaltano la dimensione di grande intellettuale ( “Nel firmamento cosmico arriva la tua riflessione…”), nonché la personalità riservata e la poetica lasciata alle nuove generazione come “sacra consegna”: “Sei puro, riservato e terreste, suppongo. / Ti arrampichi sulle alte mura, / salendo ogni singolo scalino / attraverso un continuo viaggio di autoimmersione e di monismo mistico./ Sacra consegna le tue parole, per sempre”.
La lirica, “Miracolo sotto il sole”, di Elisabetta Bagli, dedicata ai poeti Leon Felipe e Giacomo Leopardi, è poi un’attestazione d’amore alla bellezza della vita, ricostruita con immagini, figure e metafore (il viaggio, il viandante, la musica, i colori di fori,) e colta dalla poetessa nella sua essenza più vera, ora “ascoltando il battito del cuore” ora ricordando “i giorni nei quali il pianto si fece musica”, ora “riempiendo gli occhi / di multipli orizzonti / sempre più innamorata / della vita”.
Scorrendo le pagine di questa raccolta, si coglie sicuramente un crescendo di attenzione a temi di grande valenza umana come l’amore, il senso dell’ethos e del destino, tutti affidati non al caso ma ad un “Oltre”, ad un Dio che non è assente ma sta accanto ad ogni uomo per fargli comprendere che “per risanare la sua dignità / dovrà far trionfare il rispetto” . In tale ottica rifulge fortemente il senso delle liriche “Citta delle Nazioni” e “Ascolta”, “Auspicio” e “Acqua di rosa”, “Ali di gioventù” e “Viaggi dell’anima”, interessanti testi poetici ove Sofia Skleida ed Elisabetta Bagli interpretano il senso dell’ “humanitas” latina che traduce la “paideia” greca, quasi a voler liricamente disegnare un Mediterraneo come metafora dell’esistenza umana di stampo pavesiano, nella quale riflettere sui grandi temi della vita: il tema del ritorno; il tema dell’infanzia come periodo dell`esistenza umana da preferire agli altri; il tema del distacco, il tema del naufragio dell’anima, del naufragio nella nostalgia di chi torna straniero nella propria terra e non trova più i luoghi d’infanzia, i volti cari e gli amori custoditi nella propria memoria; il tema dell’amore, della solidarietà , dell’integrazione e della condivisione.
3. L’humanitas e la paideia declinate nella vita sociale
I versi delle due poetesse riescono a declinare i concetti di “humanitas e paideia” dall’astrattezza del dibattito e pensiero filosofico alla concretezza della realtà della vita quotidiana, al fine di far nascere domande nel lettore in ordine al naufragio morale e spirituale del nostro tempo; ci vengono in mente, in proposito, le parole del grande autore Lucrezio allorché scriveva: “Bello, quando sul mare si scontrano i venti e la cupa vastità delle acque si turba, guardare da terra il naufragio lontano: non ti rallegra lo spettacolo dell’altrui rovina, ma la distanza da una simile sorte”.
La potenza di questa immagine si gioca tutta sulla contrapposizione tra la terraferma, stabile e sicura, e il mare, incostante, il mare che cambia vestito in un batter d’occhio, al mutar del vento.
Lo spettatore dell’età di Lucrezio osservava la scena del naufragio stando sicuro sul solido terreno delle sue certezze, noi spettatori dell’età post moderna, sembrano dirci i versi di Skleida e Bagli, non abbiamo più, invece, queste certezze: “noi viviamo costantemente imbarcati e a rischio di naufragio”. La novità , dal secolo dei lumi in poi, è che lo spettatore, vale a dire ogni essere umano, si va distinguendo sempre meno dal naufrago, perché ogni uomo è quell’onda sulla quale va alla deriva nell’oceano della vita. Le certezze che il positivismo e le ideologie dell’epoca moderna ci avevano offerto, si sono rivelate fragili e inconsistenti e siamo rimasti perennemente imbarcati perdendoci nel naufragio della post modernità e smarrendo i punti di riferimento dell’humanitas e della paideia della civiltà greco-latina: il vivere civile, la cultura del rispetto dell’altro, della tolleranza e dell’accoglienza; e poi il decoro, che nel De officiis di Cicerone si identificava con l’applicazione delle virtù della sapienza, della giustizia, della fortezza e della temperanza, e con i doveri che ne conseguivano come l’ordine e la misura.
E sono proprio tali valori ad impregnare il logos poetico di queste due voci femminili, le quali si mettono in gioco, alla stregua di “condottiere”, per suscitare venti d’amore e comunicare al lettore che solo il “kalon”, cioè la riscoperta della bellezza e dell’armonia interiore della persona, derivante dal controllo della ragione sugli istinti, dalla fede religiosa, dalla centralità dei valori umani e cristiani, dalla riscoperta dell’importanza della collaborazione tra gli uomini, può venire la spinta all’affermazione di un rinnovato progresso sociale e di un nuovo umanesimo.
Le poesie che chiudono la raccolta Dal Mediterraneo sono proprio un auspicio, un distillato eucologico del sentire spirituale delle due poetesse che, quasi con il cuore in mano, vedono l’una nell’altra un raggio di forza per camminare nella speranza, ma che sanno anche alzare lo sguardo verso il cielo per trovare la stella da cui invocare il coraggio:
“…Il tuo sguardo maternale illumina le folle,
erige i castelli,
dona energia vitale,
congela sospiri sotterranei,
sconfigge i nemici subdoli.
Glorificato sia il tuo nome”
(Sofia Skleida, “Condottiere d’amore”)
“…Mi hai camminato accanto,
svelandomi i segreti
dei fiori e delle stelle,
degli alberi e dei fiumi,
aprendo al mondo intero
la finestra dei miei giorni.
Mi hai insegnato a vivere e ad mare,
ad accettare i miei difetti,
a capire che da sola
posso arrivare fin su in cima
per scoprire cosa mi attende
proprio lì, dietro la montagna”.
(Elisabetta Bagli, “Dietro la Montagna” )
Con un linguaggio caldo, tenue, ora descrittivo ora evocativo, ora lirico ora più concettuale, in qualche caso appesantito da indugi gnomici ma sempre di candida sensibilità , Sofia Skleida ed Elisabetta Bagli costruiscono una poetica che non si ferma alle frontiere , ma che si estende nello spazio e nel tempo con parole dal piglio parenetico; ogni loro poesia annunciando il viaggio, reclamando l’accoglienza, interrogando il male, auspicando il bene e la generosità , diventa “espressione di mediterraneità”.
Ed è proprio nelle suggestioni valoriali del “Mare Nostrum”, auspicate in tutti gli angoli del mondo, che si coglie il respiro morale e civile di questa raccolta, ove l’idea di Mediterraneo supera i confini geografici e le chiusure all’altro che viene da Sud, da Oriente o da Occidente; convinte come sono del resto, le due autrici, del fatto che la storia della cultura mediterranea, l’essenza del Mediterraneo può solo rigenerarsi attraverso lo scambio creativo che trova nella poesia, nelle lettere, nelle arti e nella spiritualità umana la spinta per far risorgere sentimenti di condivisione tra i popoli, in grado di aprire orizzonti di umanesimo capaci di diventare la dimora comune, il luogo libero e ospitale della pratica quotidiana.
Se questa silloge, già nel suo titolo, ci invita a navigare nuovamente come i nostri antenati nel Mediterraneo e a superare i confini esterni e interni della nostra memoria e lasciarci guidare dalla bellezza della poesia che in questi versi di Sofia Skleida ed Elisabetta Bagli scorre con quella “esprit de finesse” di pascaliana memoria, cioè con quella capacità di intuire il bene e l’amore quali pilastri di una società davvero umana, ebbene ci piace concludere dicendo che il mare e la poesia delle due poetesse, vissuta come “canto della bellezza e dell’amore”, hanno in comune qualcosa: il cuore! Entrambe, insomma, sembrano voler dire al lettore quanto affermava il grande Shakespeare: “la ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore: più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti”.